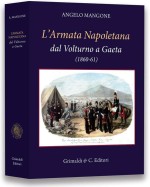José Pedro Galvão de Sousa
La rappresentanza politica
introduzione e cura di Giovanni Turco
ESI, Napoli 2009, pp. 321
€ 33,00 + spese postali
José Pedro Galvão de Sousa (San Paolo, 1912-92) fu un grande filosofo del diritto e politologo brasiliano, uno dei più eminenti esperti di diritto naturale. Fondò la Facoltà Paulista di Diritto, incorporata poi nella Pontificia Università Cattolica di San Paolo, della quale fu pro rettore e dove insegnò Teoria Generale dello Stato e Storia del diritto internazionale. Autore di numerose opere – la maggiore della quali è il Dizionario di Politica, pubblicato dopo la sua scomparsa – Galvão de Sousa espresse anche un forte impegno politico-culturale, fondando e dirigendo accanto all’amico Francisco Elías de Tejada y Spínola, storico e giusfilosofo, il mensile Reconquista, pubblicato in spagnolo e portoghese tra il 1950 e il 1952, che rappresentò la voce del pensiero tradizionalista ibero-americano. Inoltre, collaborò alla rivista Hora Presente e diede vita al “Centro di Studi di Diritto Naturale” che porta il suo nome.
Studioso profondo quanto limpido e accattivante nell’esposizione, Galvão de Sousa ci ha lasciato molte opere su diversi aspetti della politica e della dottrina dello Stato nelle quali si possono trovare le chiavi di lettura della situazione presente e delle origini storiche, filosofiche e ideologiche dell’attuale difficile relazione tra cittadino e potere politico.
Proprio uno dei suoi scritti politici, “Da representaçao política”, del 1972, viene riproposto nel volume La rappresentanza politica (ESI, Napoli 2009), a cura del prof. Giovanni Turco, ricercatore presso l’Università degli Studi di Udine ed autore del notevole saggio introduttivo.
La questione della rappresentanza, centrale in una società sempre più frazionata e globalizzata come quella moderna, è esaminata da Galvão de Sousa mettendo a confronto le diverse forme concepite da dottrine politiche che, nel corso dei secoli, si sono via via discostate dai principi del diritto naturale, assumendo i caratteri dell’assolutismo, del totalitarismo, del liberalismo, del costituzionalismo razionalistico ecc.
Lo studioso brasiliano ci ricorda che «una comunità politica è sempre una comunità storica» – si legge nel saggio introduttivo – «impregnata di valori di cultura, che la ispirano ed imprimono una direttrice al suo funzionamento», andando a costituire la tradizione che le appartiene e la connota. Essa è «‘elemento vivo e vitale’, razionalmente valutabile ed effettivamente trasmesso», non scialba imitazione o interesse antiquario; è la «trasmissione attraverso generazioni successive, di un patrimonio di valori comuni – spirituali, culturali, religiosi – conservati sempre in ciò che hanno di essenziale, corretti quando necessario, oltre che incessantemente migliorati e accresciuti». La nazione intesa in senso tradizionale non va confusa con il nazionalismo, prodotto ideologico della rivoluzione francese, né con lo Stato, che non sempre si identifica con essa, ma piuttosto con la «comunità umana nella quale si è andata definendo, nel corso del tempo, un complesso culturale sedimentato dalla storia».
La comunità sociale quindi è un organismo non un meccanismo, ed alla sua origine c’è sempre la famiglia; tra essa e lo Stato «si inseriscono altri gruppi, di diversa natura, da quella economica a quella religiosa, a quella sportiva, a partire dal municipio». Sono i corpi sociali, che la distinguono sostanzialmente da una «mera somma di individui, i quali nel loro giustapporsi possono solo dar luogo ad una massa amorfa e inconsistente, non ad un autentico popolo» e che, realizzando le proprie finalità in vista del bene comune, compongono quell’equilibrio di doveri, diritti e libertà concrete che conforma ed ordina la vita dei cittadini. «Lo Stato infrange la giustizia (e, ciò facendo, anche la sua stessa legittimità) se pretende di assorbire o surrogare quanto i singoli e i gruppi sociali (a partire dalla famiglia) possono fare con le proprie capacità e risorse»; la realizza, invece, se regola la propria funzione sui principi di sussidiarietà e solidarietà.
La visione politica di Galvão de Sousa, riconducendo ai principi immutabili ed universali del diritto naturale, rappresenta un riferimento certo per orientarsi nell’attuale scenario, che vede messa in discussione, e con motivo, la legittimità dello Stato, l’elefantiasi delle funzioni che si è attribuito, la delega di poteri ad entità ora sovranazionali ora locali in una concezione meramente economicistica ed amministrativa, la delegittimazione del ruolo dei corpi intermedi, indebolito fin quasi all’inconsistenza, in un quadro di estrema confusione istituzionale.
Tanto più in un paese come l’Italia, la cui vicenda storica diventa emblematica proprio del disagio, oggi diffuso ovunque, generato dalla frattura tra paese reale e paese legale: unificata in condizioni di illegittimità, passata attraverso una dittatura, sviluppatasi in bilico sui precari equilibri della guerra fredda,il cui principale esito è stata la disgregazione del tessuto sociale, a partire dalla famiglia, ed oggi avviata ad un processo di cosiddetto “federalismo” che trova le sue ragioni nella logica dell’interesse economico.
Proprio a questo proposito, le parole di Galvão de Sousa tornano utili per chiarire come debbano essere intesi correttamente i termini di centralismo e di decentramento.
«Dopo ogni guerra, ogni rivoluzione, ogni golpe o tentativo di sovvertimento dell’ordine, il potere dello Stato ne esce rafforzato e titolare di maggiori attribuzioni. Quante volte passano le situazioni eccezionali, ma restano i poteri straordinari che lo Stato aveva attribuito a se stesso per affrontarle. […] Fu ciò che accadde con la Rivoluzione francese e con tutti i movimenti che, in altri Paesi, hanno sovvertito l’ordine politico, per applicare i principi del 1789. Questi venivano, senza dubbio, caricati di una forte colorazione giusnaturalistica, affermando la libertà del cittadino di fronte allo Stato. Ma le libertà concrete degli uomini nelle corporazioni, nei comuni, nelle regioni, queste scomparvero. Le prime furono sacrificate alla completa libertà di produzione, di commercio, di concorrenza e le autonomie regionali e municipali furono assorbite dall’amministrazione centralizzata. Di fronte alla libertà economica individuale, diventò molto più facile per lo Stato imporre i suoi regolamenti e la disciplina legislativa. Questa rimase dipendente esclusivamente dal suo potere eretto a creatore del diritto, potere che non trovava più dinanzi a sé le barriere dei privilegi regionali o delle attribuzioni normative prima riconosciute alle realtà corporative. La mancanza di resistenza sociale rese possibile l’accrescimento delle attribuzioni del potere politico. Solo le forze economiche, costituite, a margine dei gruppi intermedi, attraverso la concentrazione capitalista, potevano controllare la macchina statale, come di fatto cercavano di fare, servendosi di un apparato tanto formidabile per ottenere il dominio del mercato.
Così il potere passò ad essere un elemento aggressivo nei confronti della società. Il potere politico e il potere economico. L’autorità dello Stato, la cui ragion d’essere è di assicurare l’ordine sociale, si perverte, allora, in un fattore distruttivo di quest’ordine. […]
A quale risultato finale ha condotto questa aggressione della società da parte dello Stato? A che cosa ha portato questo attacco del potere politico – molte volte controllato dal superpotere economico – contro i poteri liberamente costituiti nella società? Bertrand de Jouvenel risponde: «Alla distruzione di qualsiasi comando, a profitto del solo comando statale. Alla piena libertà di ognuno rispetto alle autorità familiari e sociali, compensata da una piena sottomissione allo Stato. Alla perfetta uguaglianza di tutti i cittadini tra loro, a prezzo del loro uguale annichilimento da parte dello Stato, signore assoluto. Alla sparizione di ogni forza che non provenga dallo Stato, alla negazione di qualunque superiorità che non sia quella dello Stato. In una parola, all’atomizzazione sociale, alla rottura di tutti i vincoli personali tra gli uomini, i quali possono mantenersi uniti solo in una comune servitù allo Stato. Infine, per una convergenza fatale, agli estremi dell’individualismo e del socialismo». […]
Centralizzazione e decentramento, lungi dall’essere idee antagoniste, non si escludono l’una con l’altra, ma anzi si completano. Il decentramento risulta da un principio di giustizia. Consiste nel trattare ognuno ciò che è proprio, sia esso l’individuo, il gruppo familiare, il gruppo professionale, il municipio o la provincia. Sul piano dell’interesse nazionale, allo Stato spetta una legittima centralizzazione, i cui limiti derivano dal decentramento sociale. […]
Il male non si trova, quindi, nella centralizzazione, ma nella centralizzazione esclusiva ed assorbente. La centralizzazione per se stessa non è totalitaria, ma va ad assumere questo carattere quando esclude il decentramento nel senso più ampio, cioè il decentramento sociale. Nessuno contesterà allo Stato il diritto di esercitare, in modo esclusivo, attribuzioni concernenti la difesa nazionale, la diplomazia, la polizia, la direzione generale delle finanze. Molte altre attività, tuttavia, non spettano allo Stato se non in maniera suppletiva, dovendo essere rispettata l’iniziativa privata e riconosciuta la capacità disciplinare e normativa delle comunità autonome. […]
D’altronde, il termine decentramento può prestarsi ad equivoci. È un errore vedere nel decentramento soltanto una concessione o il conferimento di diritti da parte dello Stato a collettività non statali; nel caso si tratterebbe di un favore, di un regalo, di una donazione generosa. Il decentramento sociale deriva dal riconoscimento, da parte dello Stato, di attribuzioni naturali appartenenti a quelle collettività in virtù dei loro fini e dell’autonomia che loro compete. E molte volte il termine «decentramento» (da «trarre dal centro») deve essere applicato per significare la restituzione, a questi stessi gruppi, di funzioni usurpate dallo Stato.
L’eccessiva centralizzazione dello Stato moderno […] è stata una conseguenza della distruzione delle libertà particolari a vantaggio di una libertà generale e astratta, combattuta poi in nome dell’uguaglianza, a sua volta generatrice di uniformità e di centralizzazione. Lo osserva Louis Daujarques, evocando le seguenti parole di Royer-Collard davanti alla Camera dei deputati, nel gennaio del 1822: «La Rivoluzione non ha lasciato in piedi se non gli individui, e da questa società polverizzata derivò la centralizzazione, poiché dove non vi sono che individui tutti gli affari che non sono propri sono affari pubblici, affari dello Stato. Fu così che noi siamo diventati un popolo di amministrati».